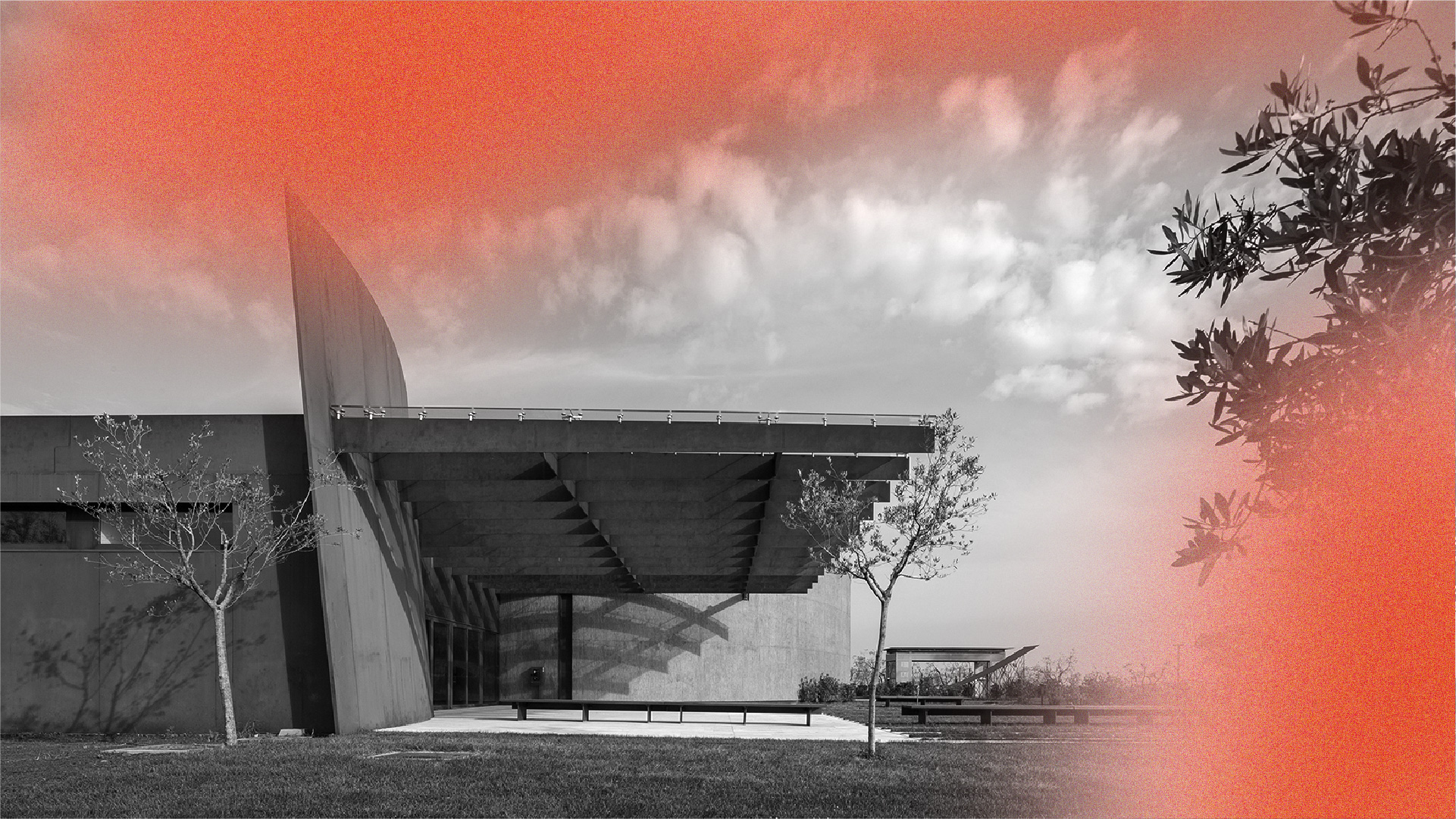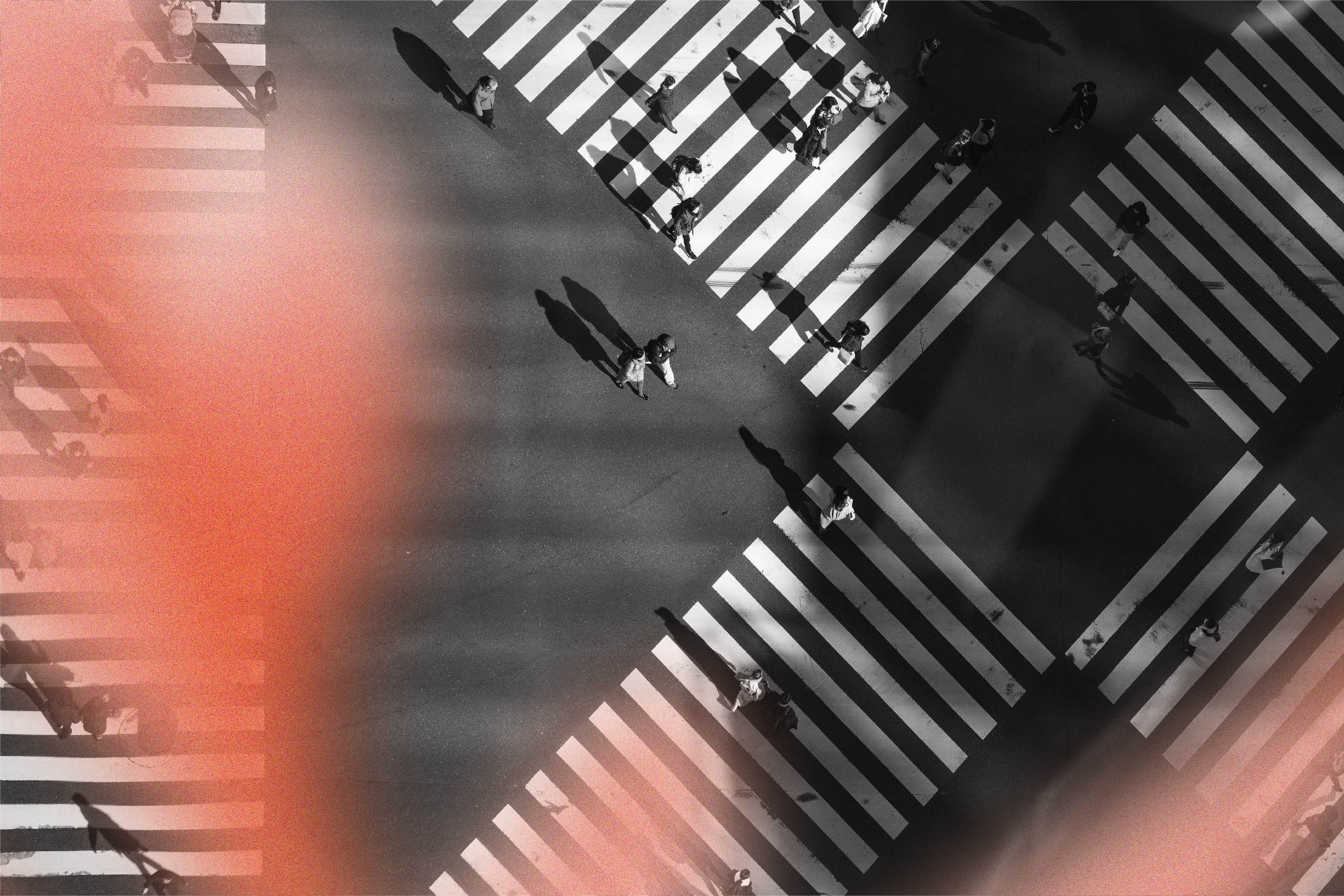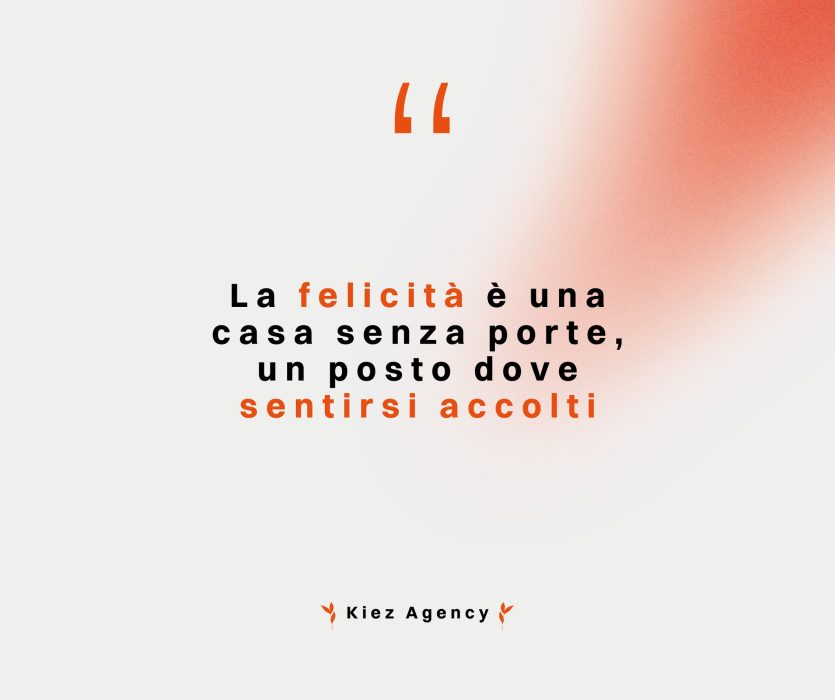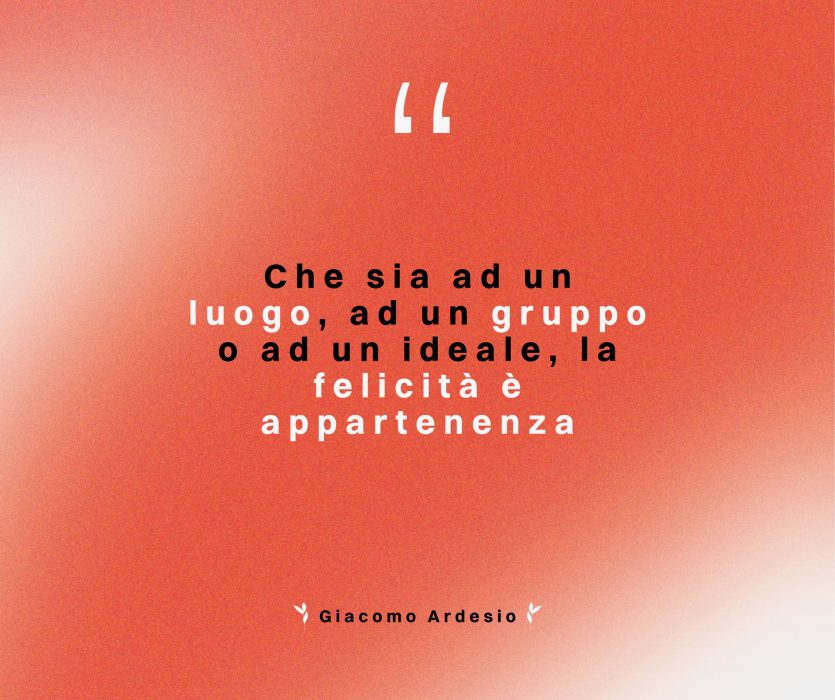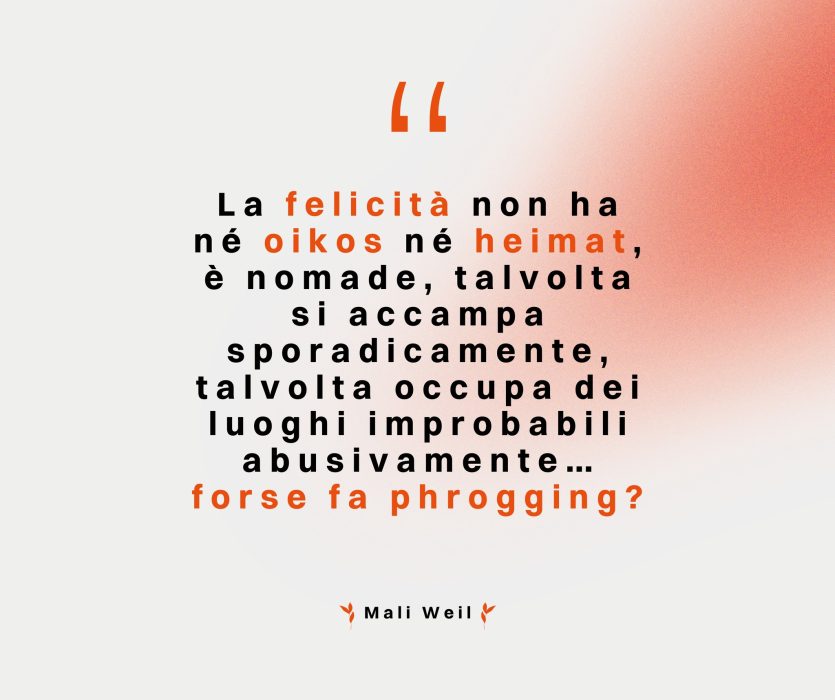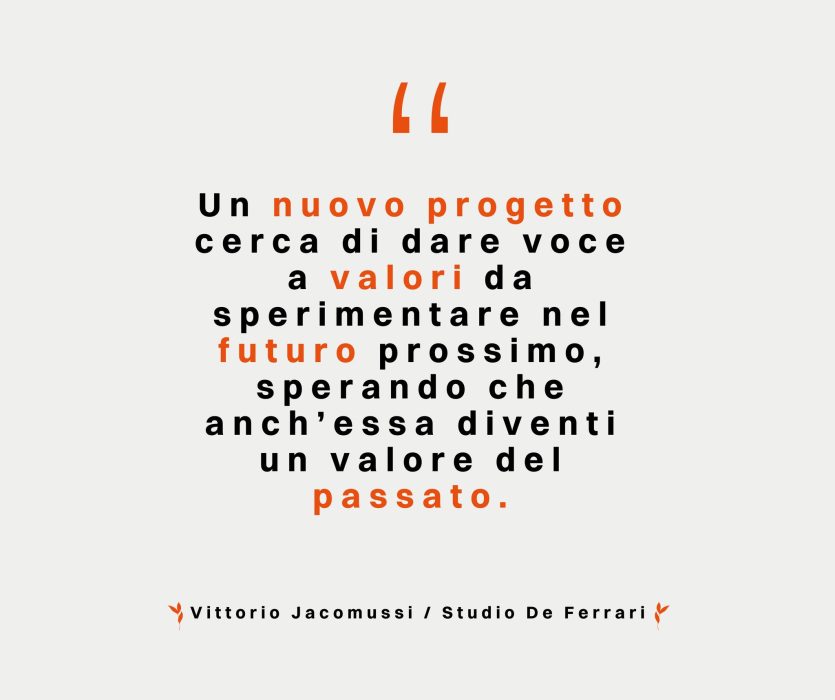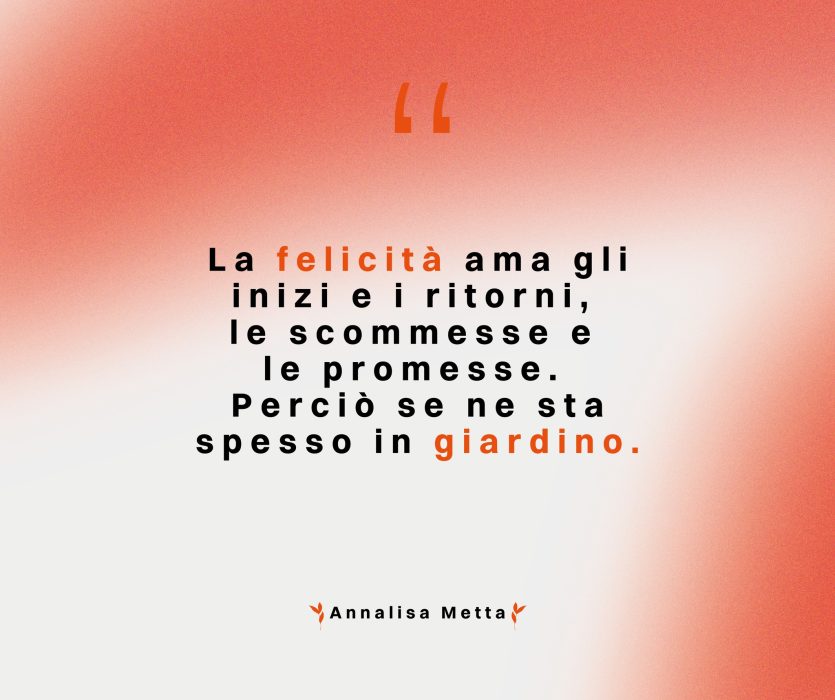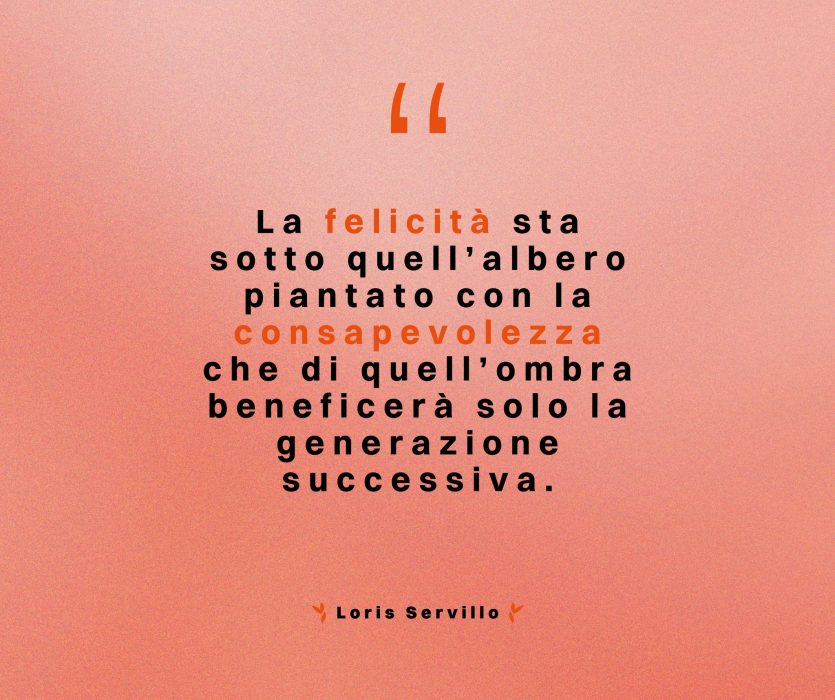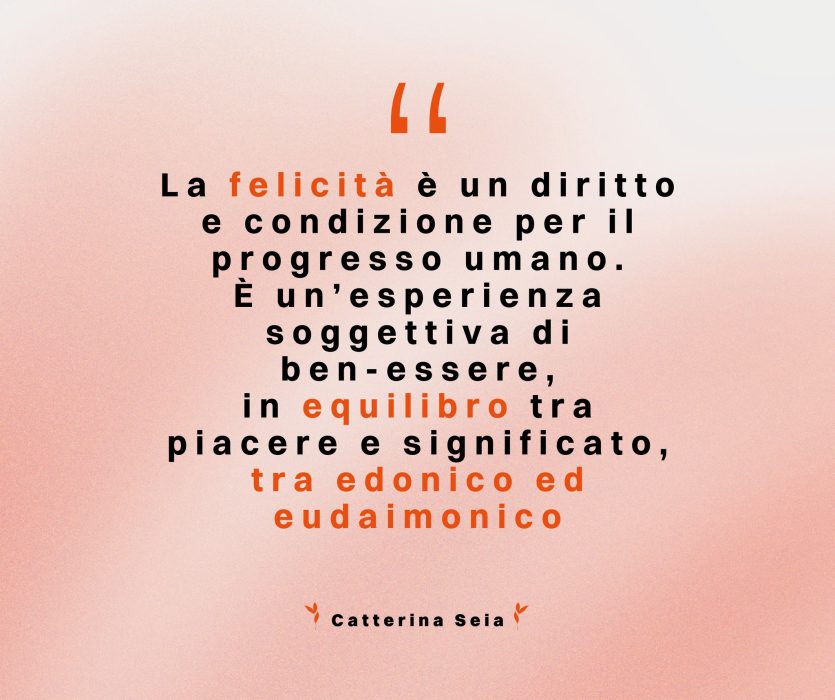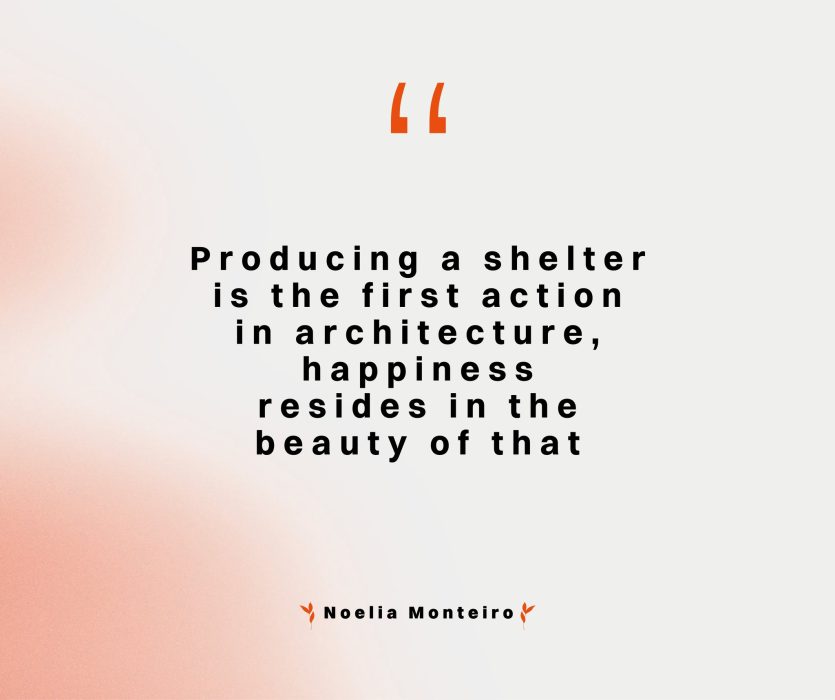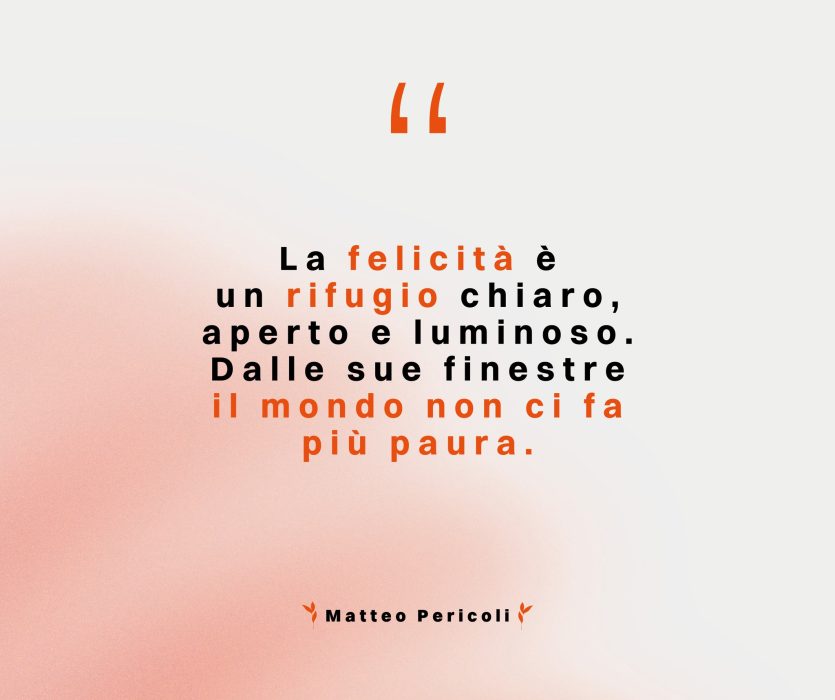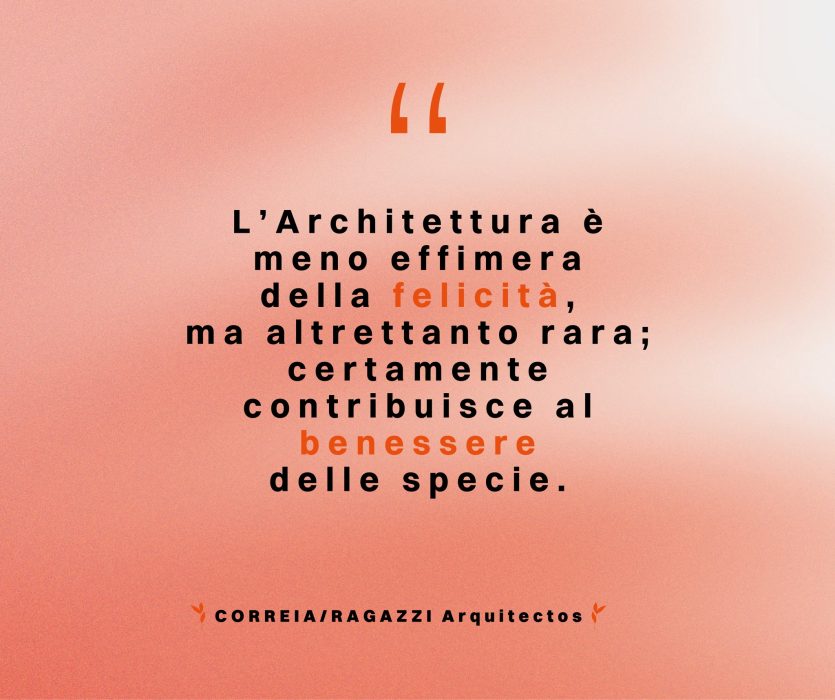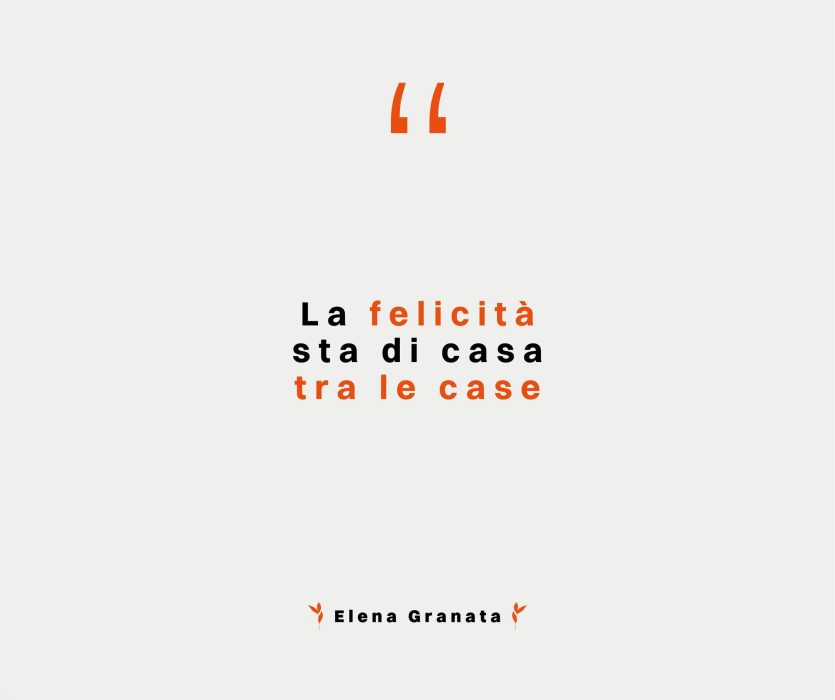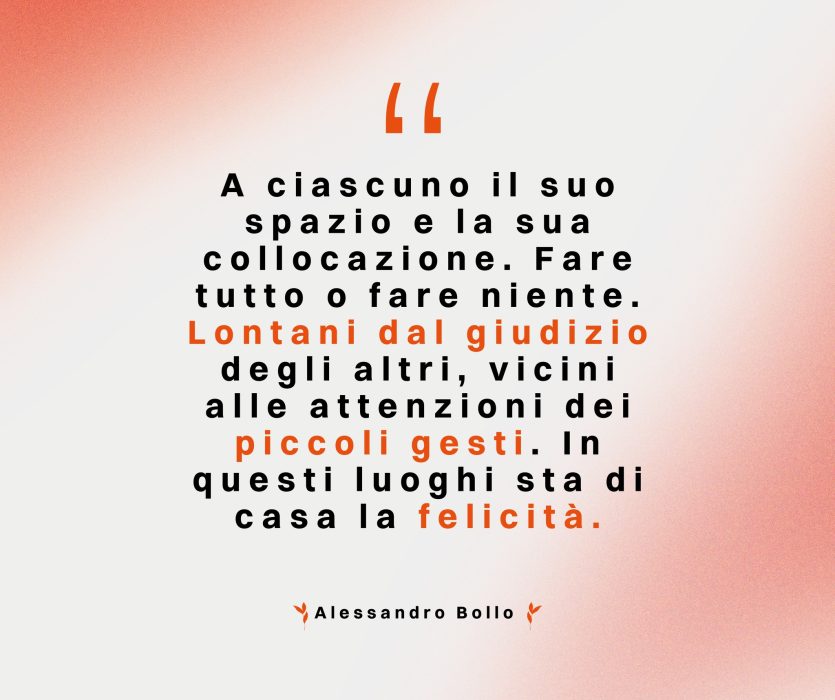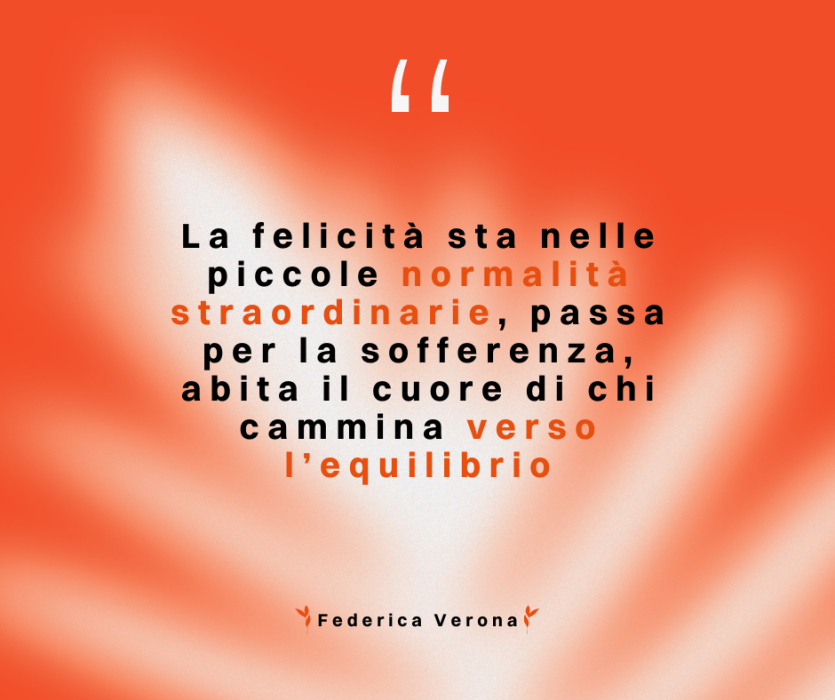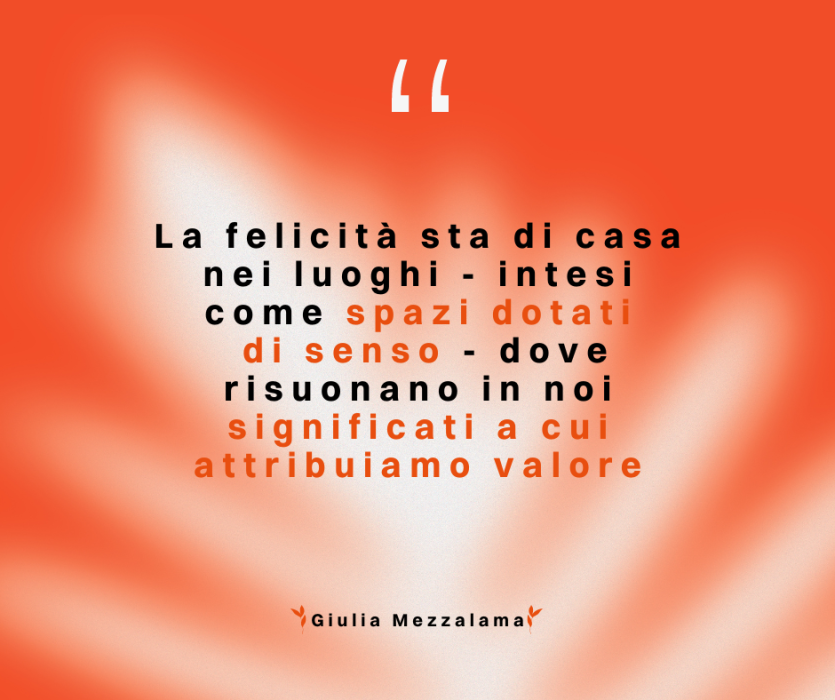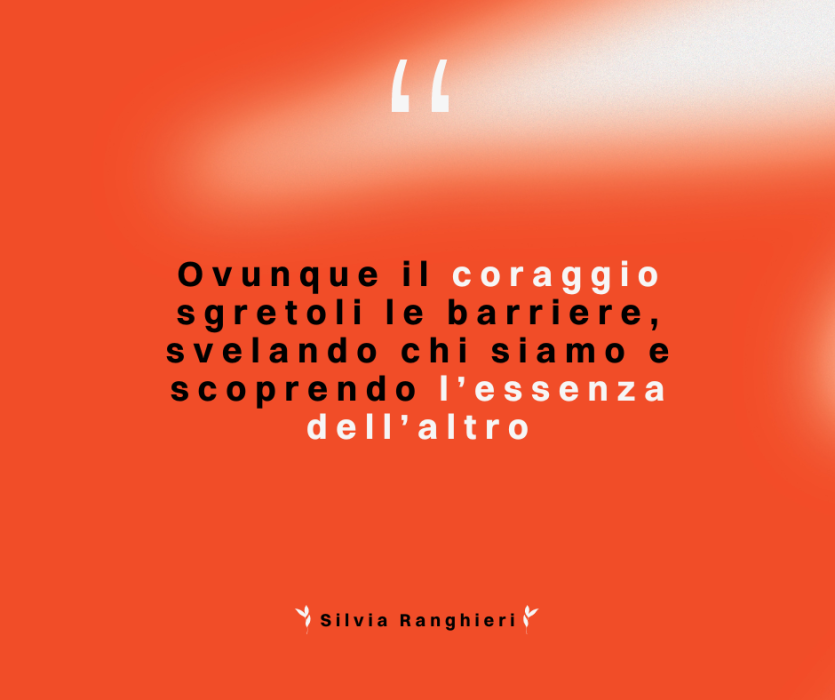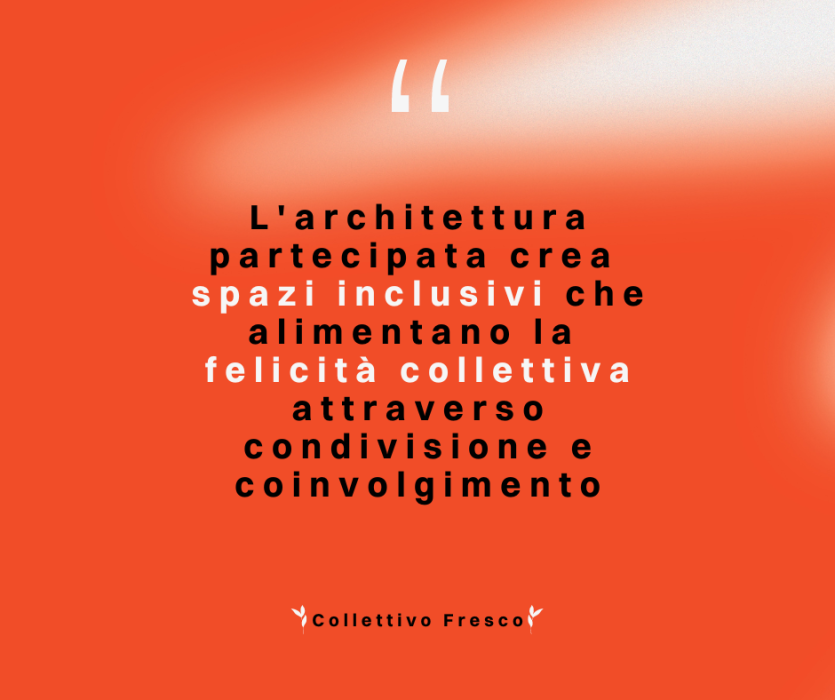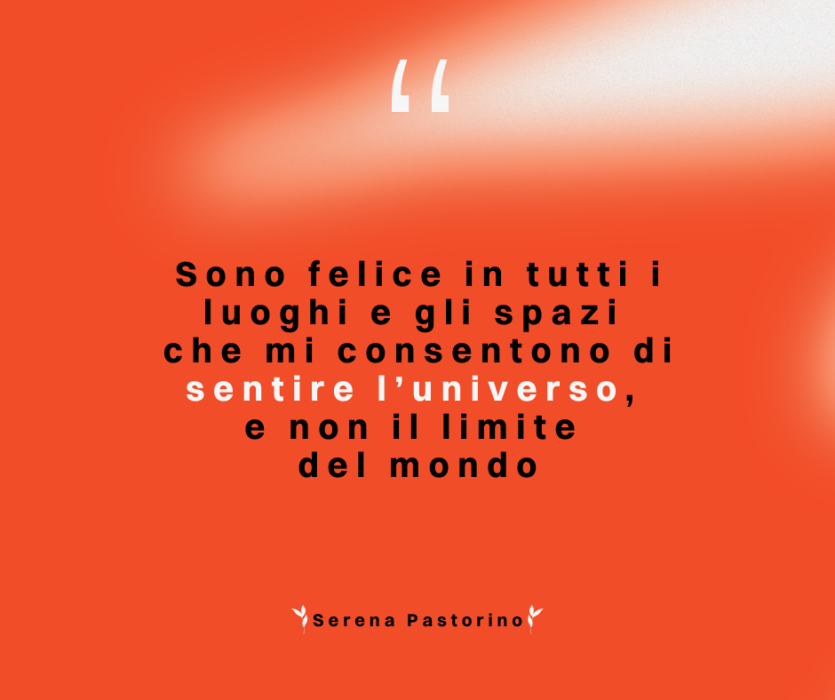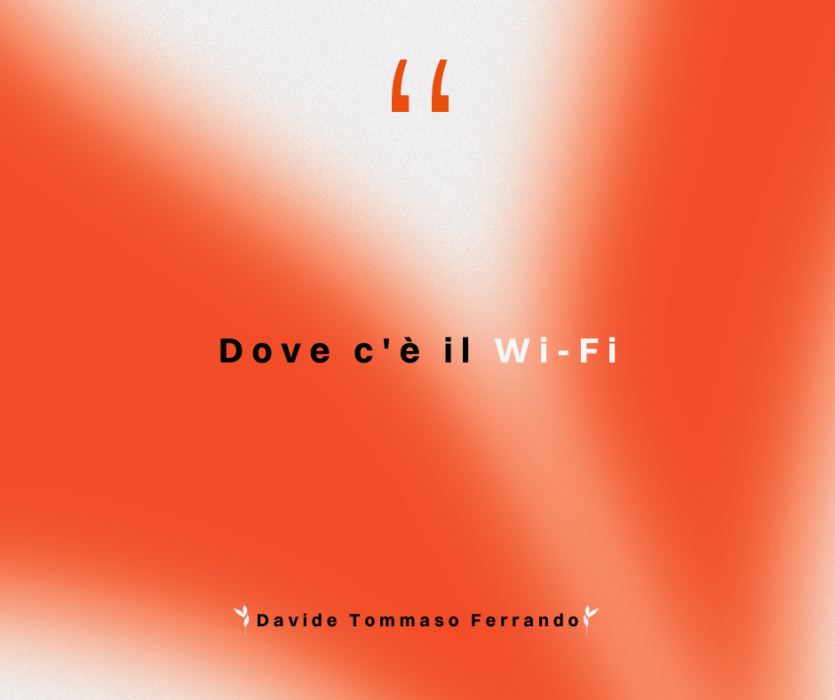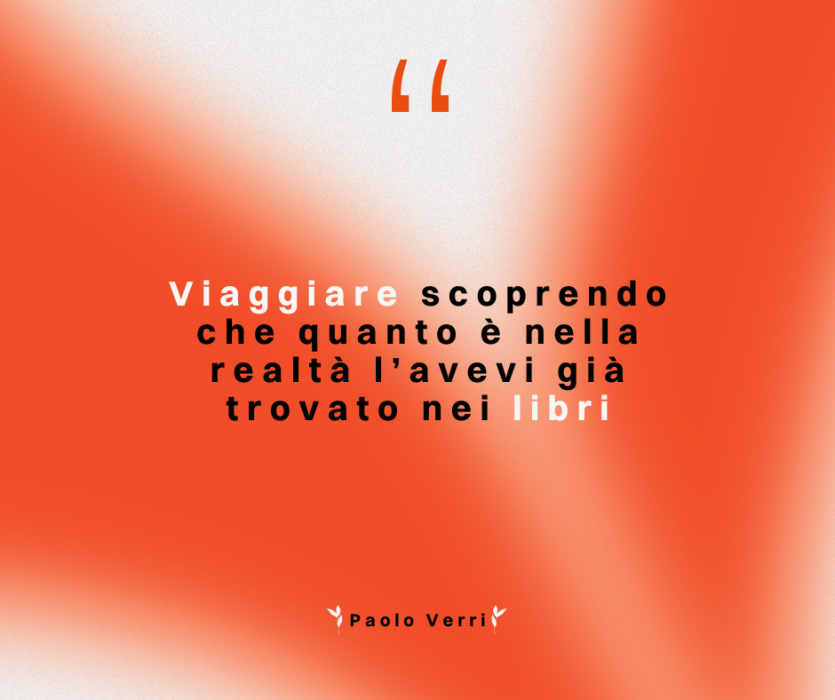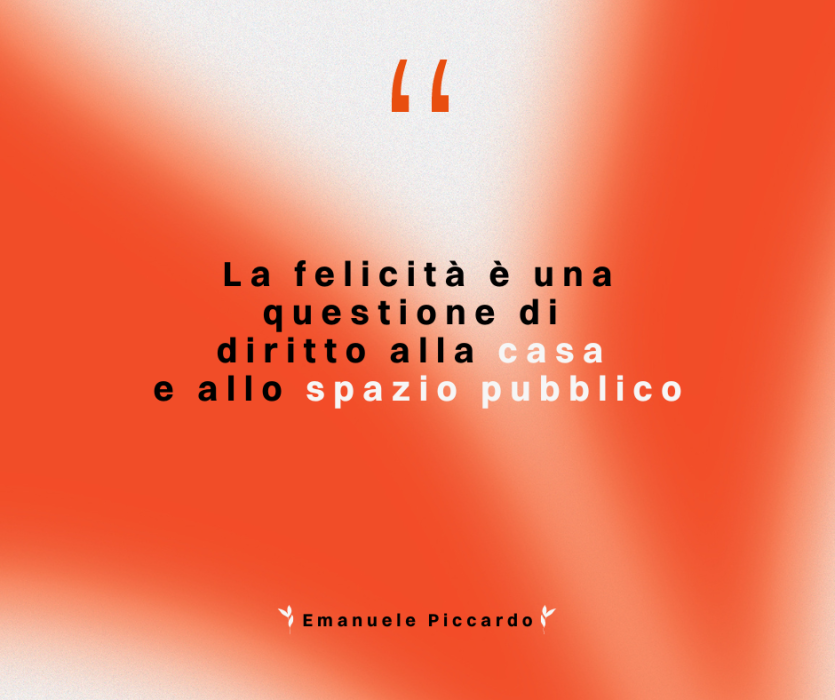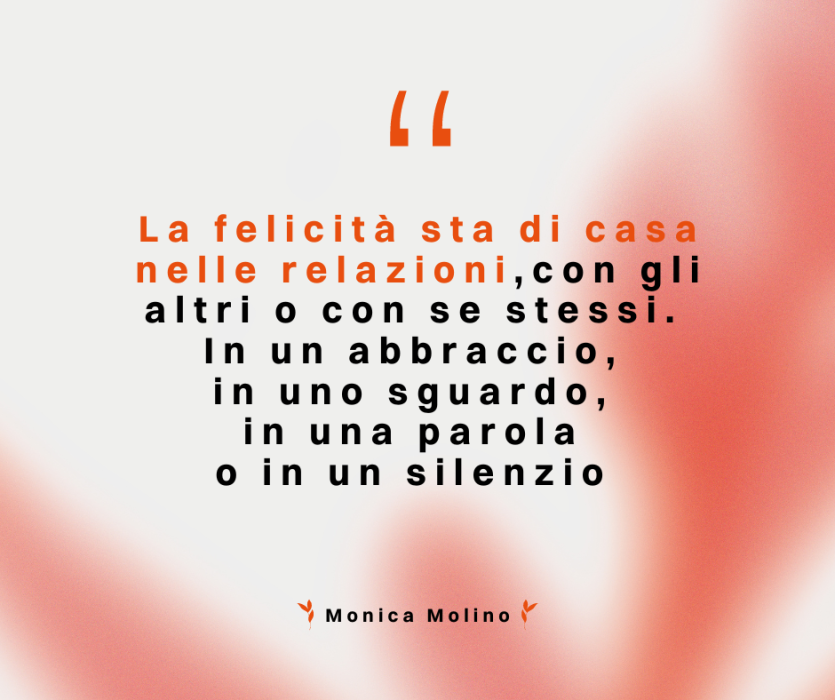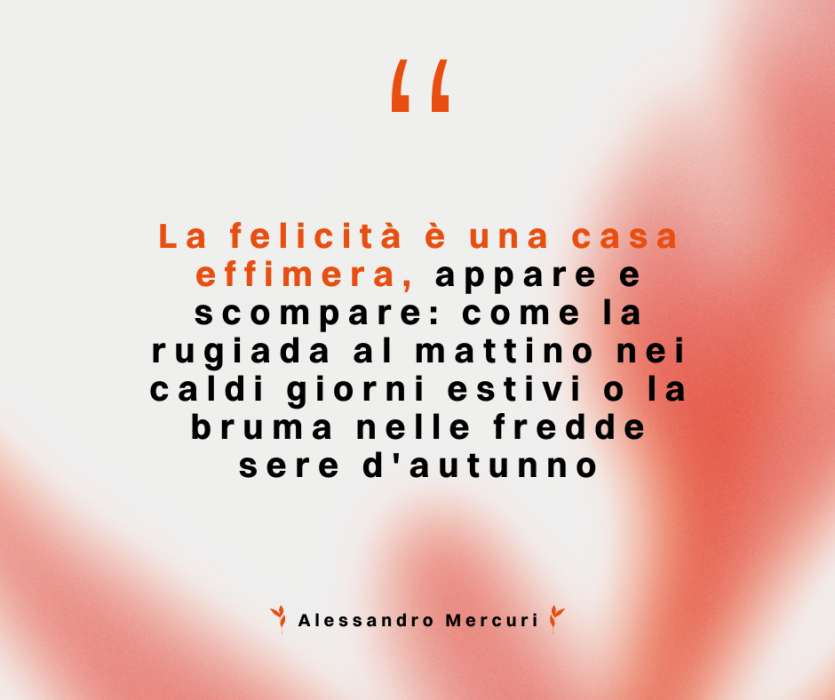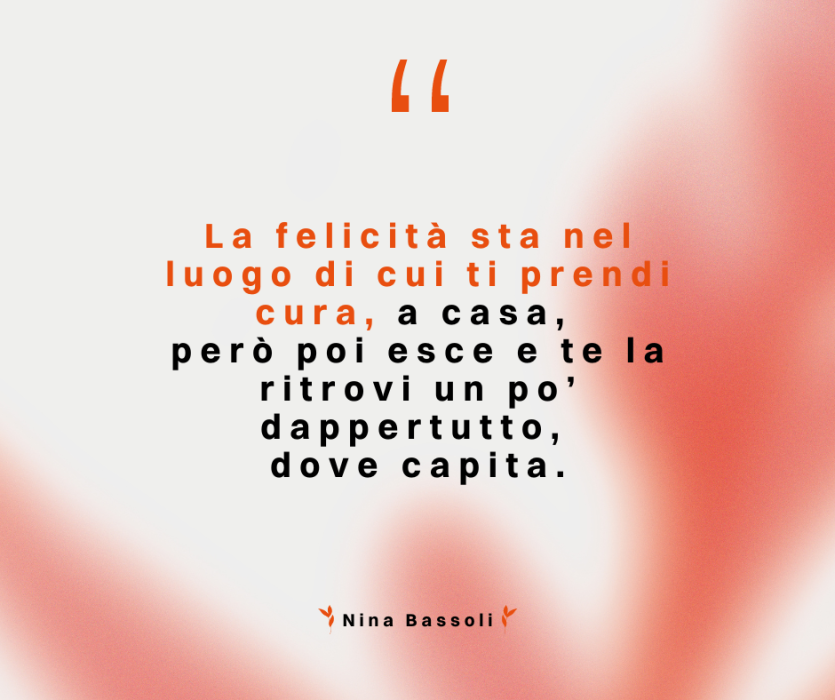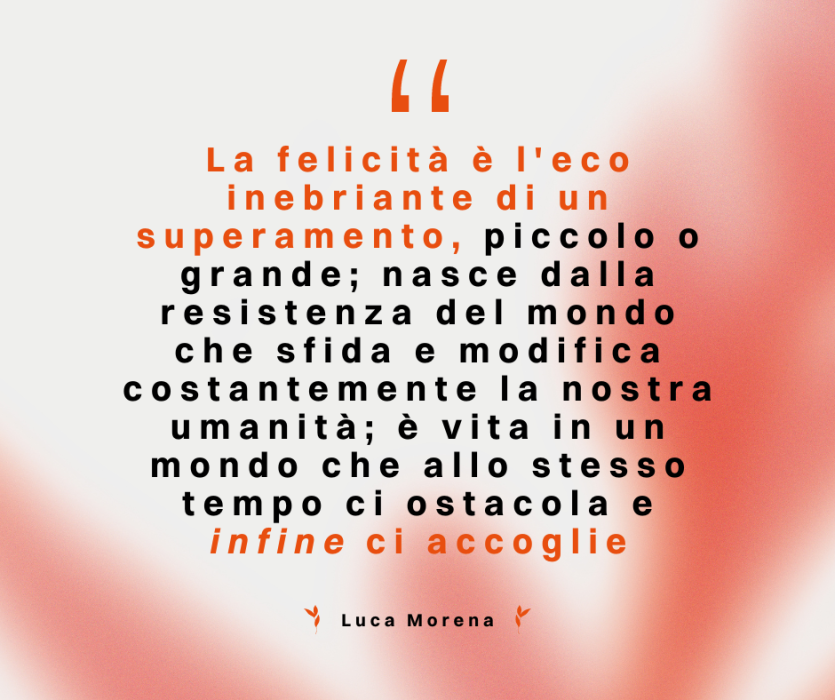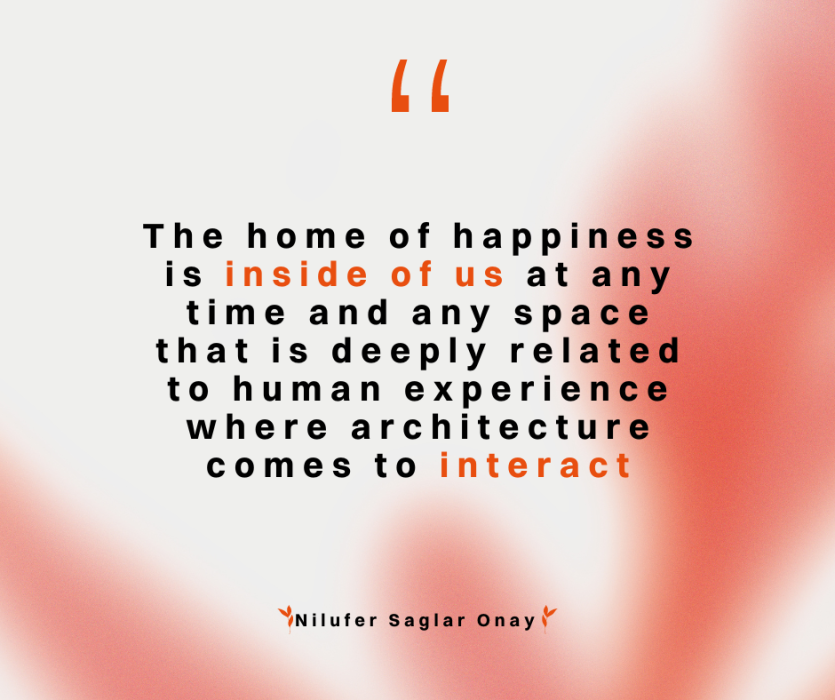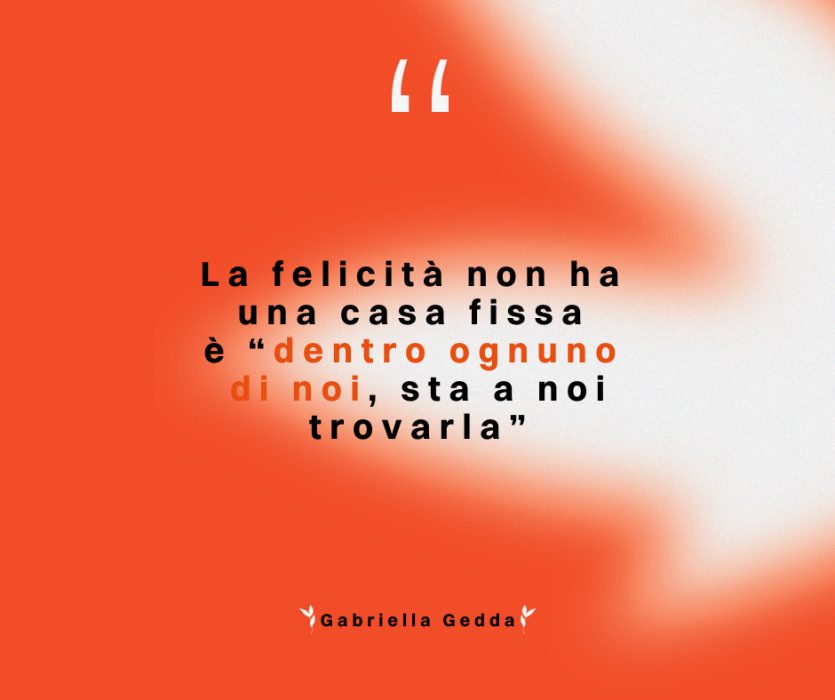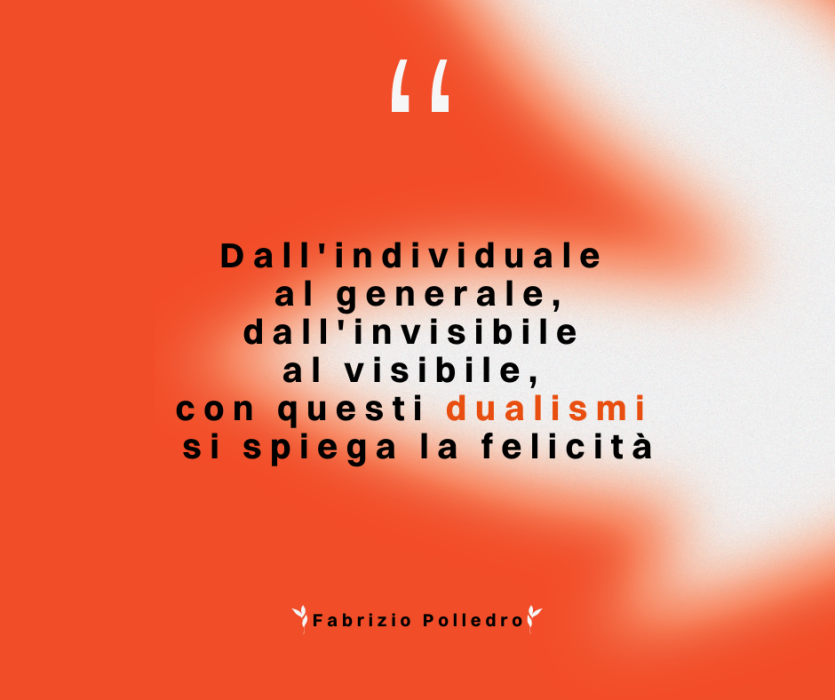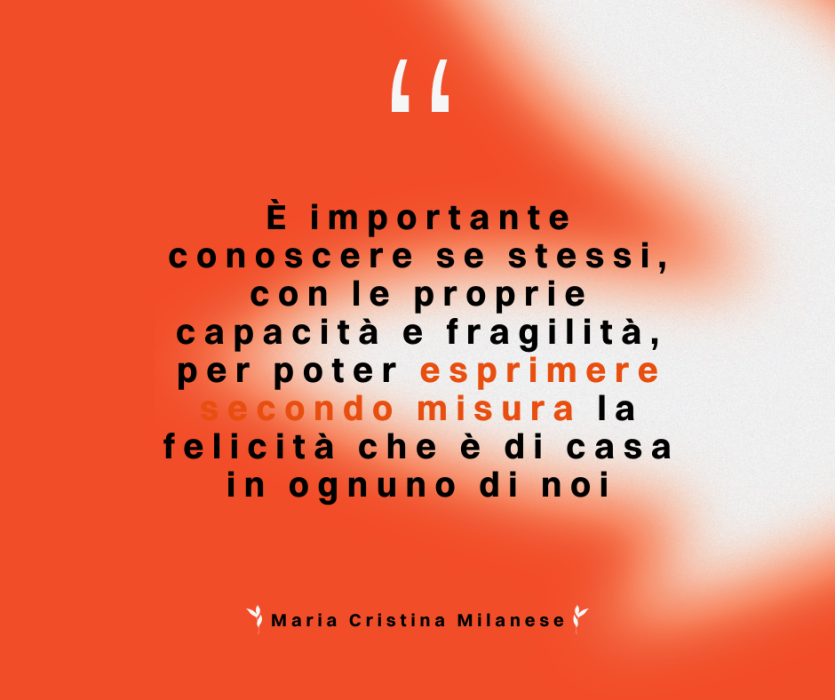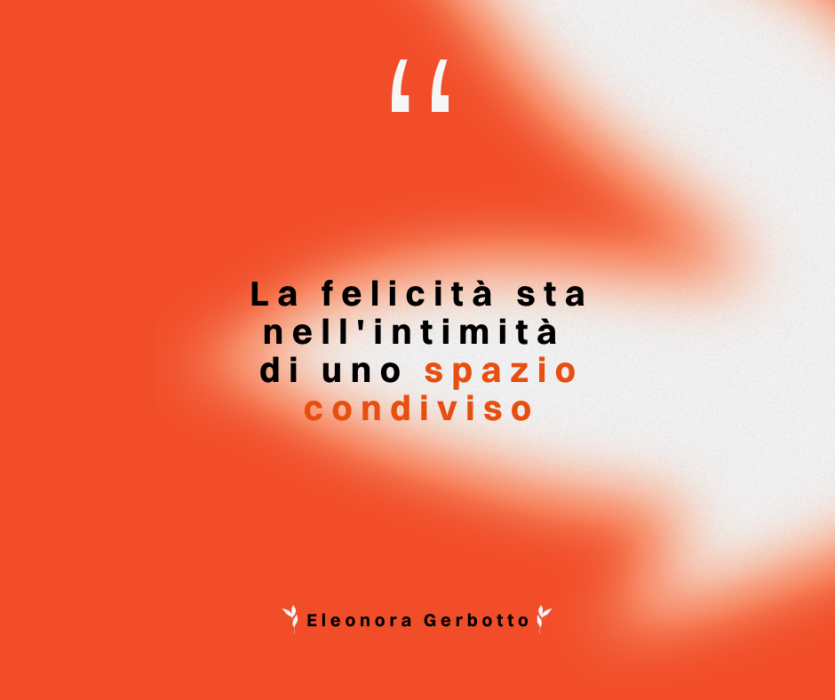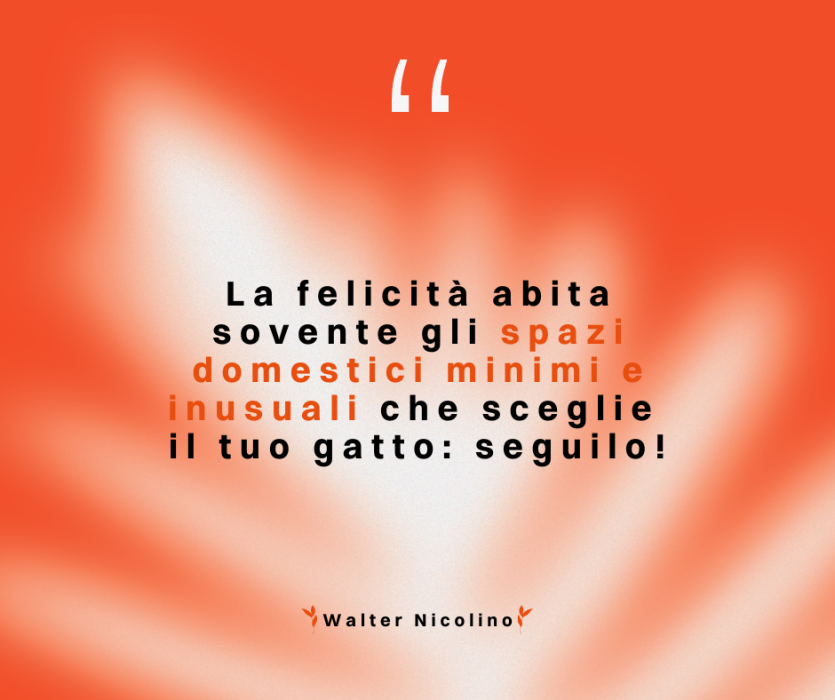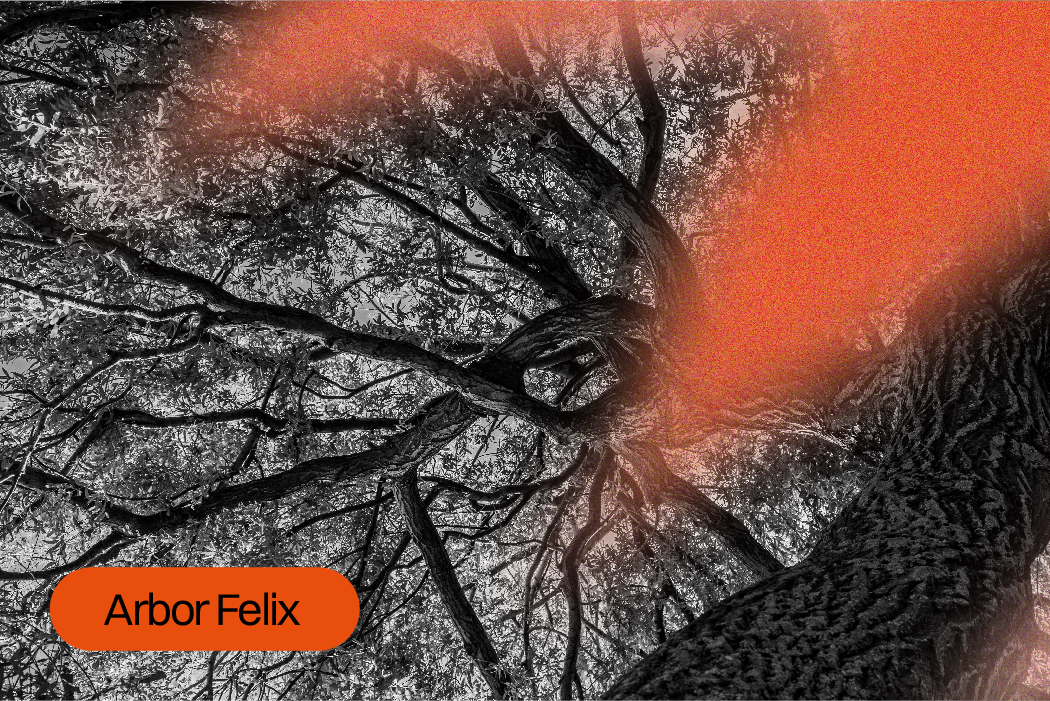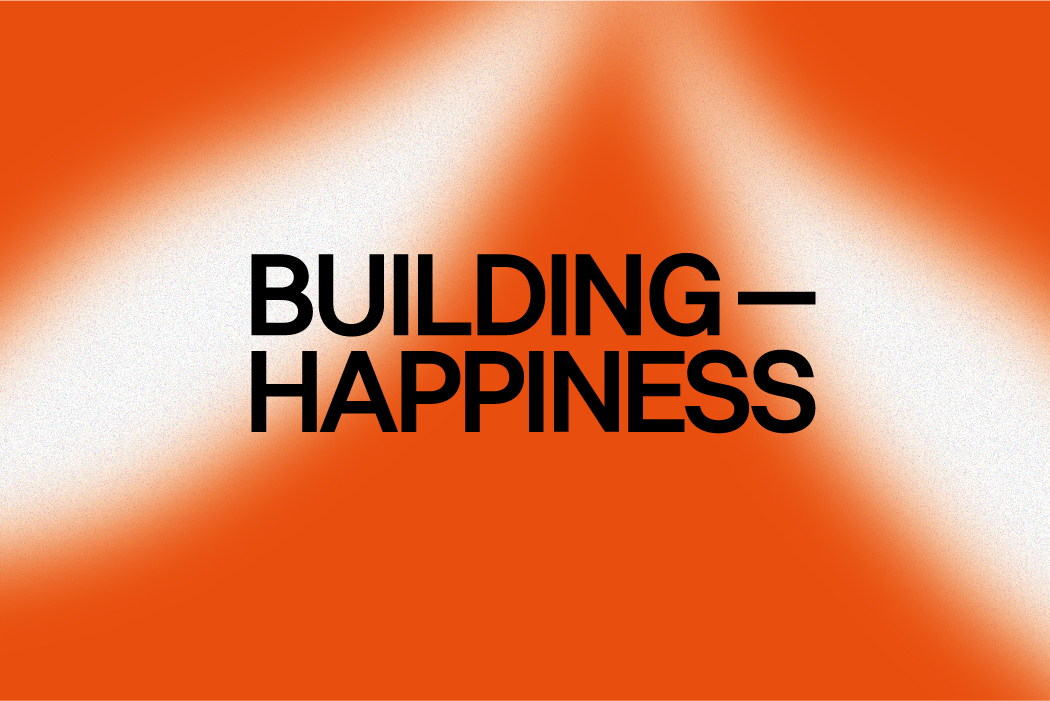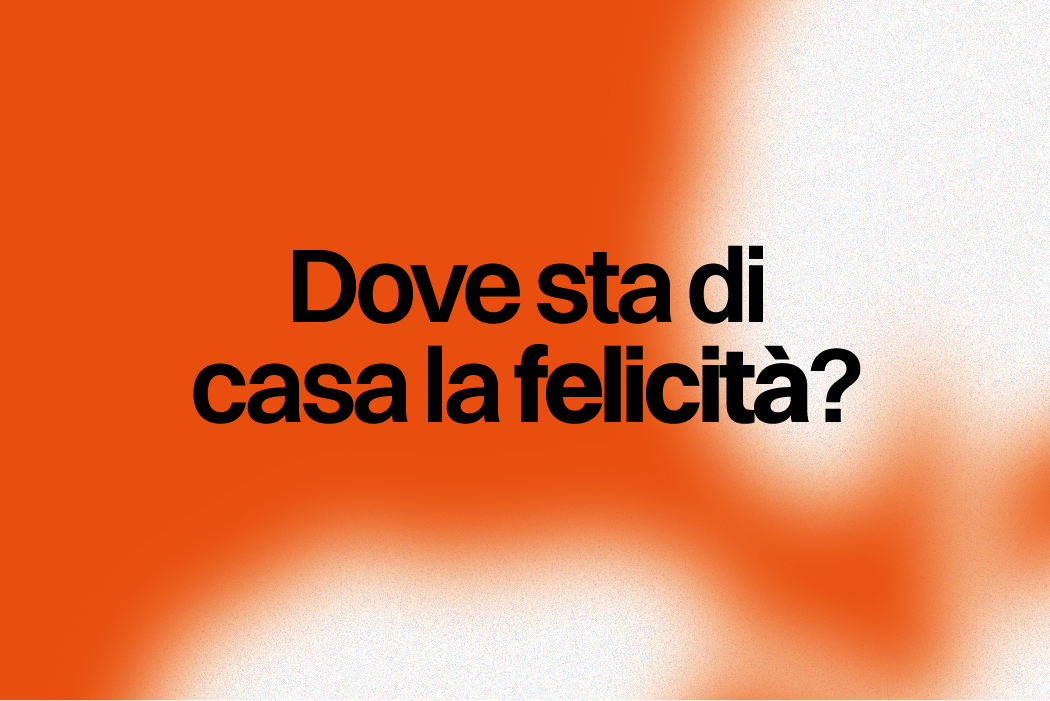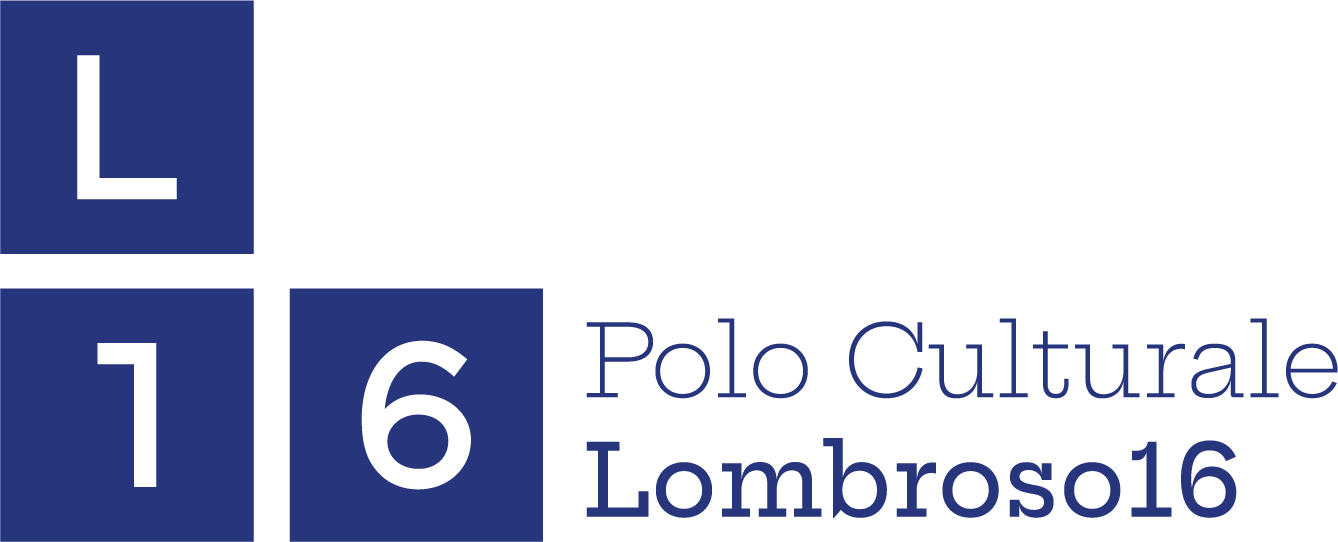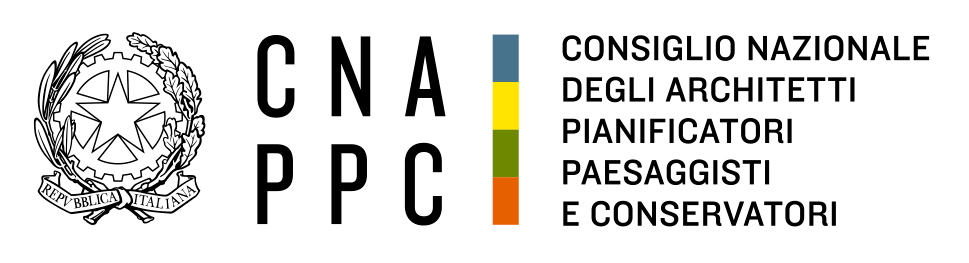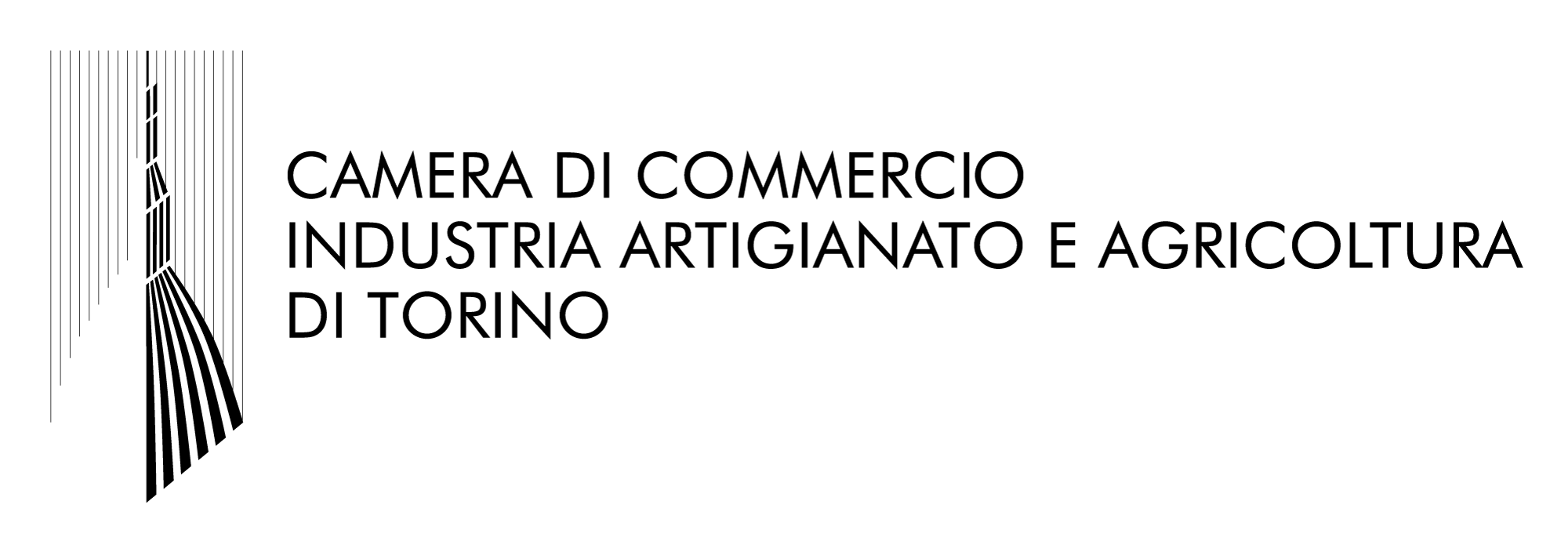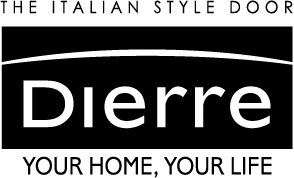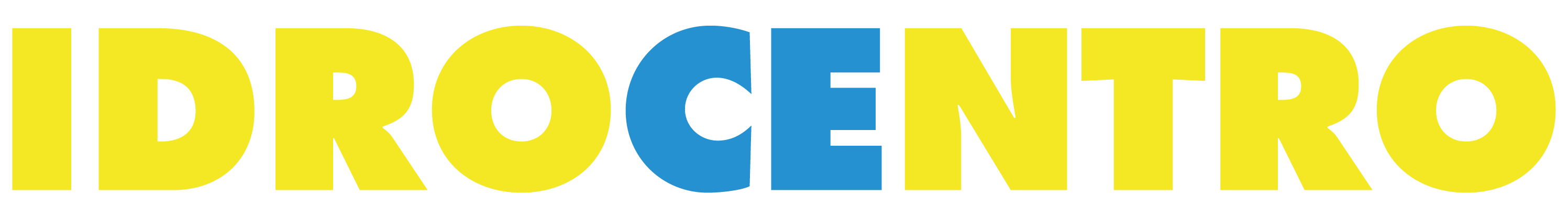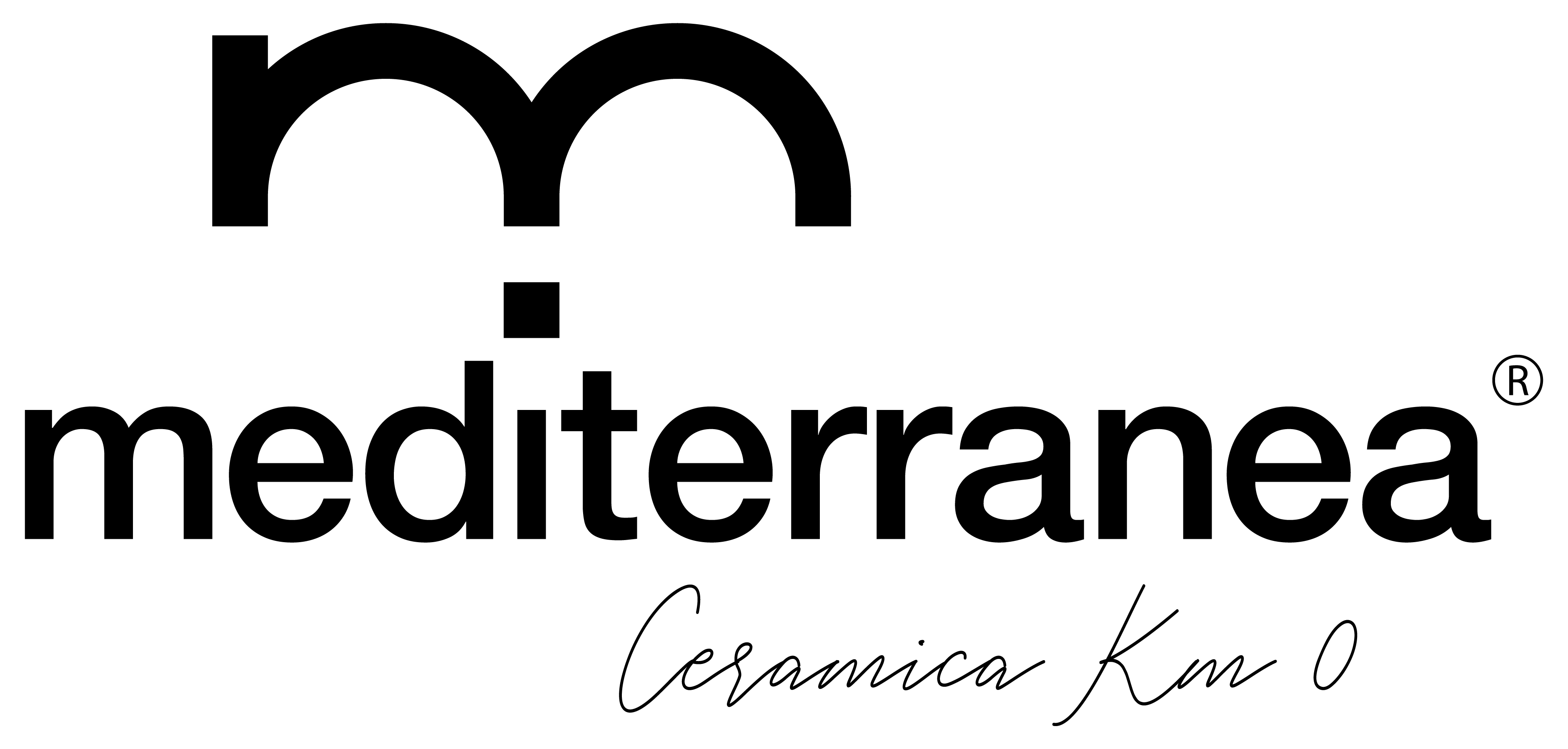Che cos’è la felicità? È una condizione mutevole e momentanea di benessere, comfort e gioia. Coinvolge l’emotività, l’intelletto e il corpo: è dunque uno stato soggettivo dipendente da molte variabili. Possiamo dedurre che non esiste una sola felicità valida per tuttɜ, ma tante felicità quanti sono «i mondi che si trovano nella mente degli uomini» (John Kirtland Wright).
Ma può l’architettura influenzare la nostra felicità? E, se sì, è possibile misurarne gli effetti? Sono le domande a cui il progetto Building Happiness della Fondazione per l’architettura intende rispondere, guidando un’esplorazione generativa rivolta a tuttɜ, i cui risultati forniscano risposte efficaci alle comunità e offrano spunti per una rivoluzione dell’approccio progettuale.
Per tutto il 2024 Building Happiness vi accompagnerà in un lungo un percorso di incontri, approfondimenti ed esperienze per indagare la relazione tra spazi e felicità.
Un programma caleidoscopico che mette in relazione l’architettura con molteplici discipline, sei format dedicati a un pubblico curioso e intergenerazionale.
- Talk – Happiness on stage
- Marathon – Stand up for architecture
- Face to Face – Meet architecture
- Book Lab – Happiness between lines
- Happy places – Discover architecture
- Photo Contest – Look at that happiness!
Diventa protagonista di Building Happiness e aiutaci a portare avanti la nostra esplorazione rispondendo al questionario on line, messo a punto per riflettere collettivamente sugli effetti che gli spazi costruiti generano sulle nostre emozioni.
Bastano pochi minuti e puoi rispondere ovunque: in ufficio, a casa, in spazi aperti, privati o pubblici.
Ogni luogo può generare felicità, ma dove accade davvero? E come?
Gli esiti del questionario, raccolti e analizzati dal team di esperti della nostra Masterclass, ci aiuteranno a definire le linee guida per una progettazione felice.
Tra gli obiettivi di Building Happiness la redazione del Building Happiness Book: il libro d’istruzioni per progettare la felicità.
Il libro racchiuderà indicazioni tecniche, riferimenti teorici, case studies e un corpo visivo di diagrammi e disegni.
Tutto il materiale sarà pubblicato on line per far sì che progettistɜ, architettɜ e studiosɜ ne possano fruire liberamente, aggiungendo così un tassello importante al “discorso sulla felicità”, già affrontato da altre discipline.
Il Building Happiness Book sarà presentato pubblicamente durante l’evento di chiusura della programmazione prevista per gennaio 2025.